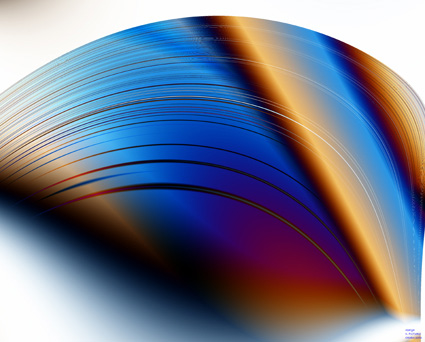Complesso è probabilmente il termine psicoanalitico che ha incontrato maggior favore presso il pubblico: avere dei complessi, essere privi di complessi, essere complessati, avere il complesso di… (di Edipo, di inferiorità, del medico, dei soldi ecc.), sono espressioni entrate a far parte del gergo colloquiale, con una coloritura, volta a volta o contemporaneamente, pretenziosa, sarcasticamente approssimativa, misteriosa, scherzosa. Eppure “complesso” non è un vocabolo che goda in generale di grande considerazione all’interno della comunità psicoanalitica. Esiste cioè un divario abbastanza netto tra l’uso corrente e l’uso “tecnico” della parola.
Nel linguaggio comune, come spesso accade, il termine esprime un concetto abbastanza vago ed elastico, mantenendo comunque un nucleo semantico sufficientemente stabile per azzardarne una illustrazione:
a) “complesso” fa riferimento innanzitutto a una qualche distorsione, anomalia, deviazione della mente, che ha insieme qualcosa del “vizio” (che come tale deve essere biasimato e condannato) ma anche della “malattia” (che merita pertanto comprensione e pietà e che, soprattutto, conferisce il diritto a una terapia);
b) è qualche cosa di peculiare di alcuni individui, che proprio dal loro personale “complesso” risultano caratterizzati e contraddistinti;
c) benché costituisca un “difetto”, deve essere giudicato come un fatto non grave, che può essere guardato con ironica e divertita benevolenza, non disgiunta da un certo rispetto per la complicatezza psicologica di cui è segno;
d) infine “complesso” indica che la mente dell’individuo è tutta presa da una qualche idea “eccessiva” o sbagliata intorno alla quale ruotano tutti i suoi pensieri, sentimenti, comportamenti, che di quell’idea portano l’impronta e a quell’idea direttamente o indirettamente sono collegati.
Quest’ultimo significato è, con buona approssimazione, il più vicino al significato che il termine ha in psicoanalisi (o al significato che in origine gli venne attribuito). Ma le sfumature di significato, tutt’altro che marginali, indicate nei punti precedenti, contengono in nuce i motivi ispiratori di una “psichiatria popolare”. Di una psichiatria cioè, che ha un’origine molto più lontana nel tempo che non la psichiatria scientifica e che è costruita essenzialmente sulla coniazione di epiteti, ingiuriosi e scherzosi insieme, che servono a individuare alcuni “tipi psicologici” abnormi (come si vedono fissati ad esempio nella commedia dell’arte) e di cui la psichiatria e la psicologia scientifiche sono inconsapevolmente debitrici. Una psichiatria popolare in cui l’ispirazione moralistica è corretta da benevola tolleranza e condiscendenza ed i vizi, le anomalie, le deviazioni, le stranezze non sono altro che l’esasperazione caricaturale delle debolezze di tutta l’umanità. Il termine “complesso” introdotto nel linguaggio comune ha dunque subito l’influenza di una più solida tradizione popolare che ha imposto un condizionamento del concetto al proprio modo di vedere e di trattare la psicopatologia. E tutto ciò ha anche alcune somiglianze con le vicende a cui è andato incontro il termine “complesso” nella stessa storia della psicoanalisi.
Nella letteratura psicoanalitica la parola fu introdotta alla fine del 1800 da Joseph Breuer (maestro e collaboratore di Freud ai tempi in cui venivano poste le basi della psicoanalisi) e poi adoperata dallo stesso Freud già nei suoi primi scritti. Il termine veniva usato in un’accezione abbastanza generica e non assumeva particolare rilievo nell’ambito di un discorso di portata ben più ampia che aveva di mira la definizione del concetto di inconscio e delle leggi che presiedono al suo funzionamento e ai rapporti con l’attività psichica cosciente. Più o meno agli inizi del 1900 C.G. Jung era impegnato a studiare le leggi che determinano il susseguirsi delle “associazioni ideative” attraverso una tecnica di indagine che consisteva nell’invitare i soggetti che si sottoponevano alla prova, a dire, il più rapidamente possibile, la prima parola che si presentava alla loro mente in risposta ad ognuna delle parole pronunciate dall’esaminatore. Questi esperimenti associativi dovevano rivelare che, per alcune parole-stimolo differenti da soggetto a soggetto, si provocavano una serie di perturbazioni nelle modalità delle risposte: tutto ciò sembrava non consentire altra plausibile spiegazione se non la capacità che possedeva una determinata parola (priva in se stessa di particolare risonanza emotiva) di andare a smuovere, in un determinato soggetto, un qualche suo intimo nucleo di problemi, rivestito di un forte contenuto affettivo, di cui il soggetto non aveva chiara consapevolezza. Jung diede a tali nuclei di problemi il nome di “complessi”: la corrispondenza con le osservazioni di Breuer e Freud sembrava, con tutta evidenza, non risiedere semplicemente in una mera coincidenza terminologica. E Freud accolse inizialmente con estremo favore la scoperta di Jung che prometteva di prestare una certa dignità scientifica alle sue affermazioni desunte dalla pratica clinica. Ben presto tuttavia Freud avrebbe dovuto ricredersi sulla possibilità di inserire nella sua elaborazione teorica il concetto di “complesso” nell’accezione che veniva proposta da Jung (che era poi la versione che iniziava ad affermarsi sia presso gli studiosi che presso il pubblico).
Una definizione di “complesso” coerente con il pensiero di Freud è quella proposta da Laplanche e Pontalis (Enciclopedia della psicoanalisi; vol. 1):
<<Insieme organizzato di rappresentazioni e di ricordi con forte valore affettivo, parzialmente o totalmente inconsci. Un complesso si costituisce a partire dalle relazioni interpersonali della storia infantile e può strutturare tutti i livelli psicologici: emozioni, atteggiamenti, condotte adattate>>.
In questa definizione viene messo in evidenza che l’origine del “complesso” si situa in qualche vicenda, reale o immaginaria, interpersonale dell’infanzia. Non è superfluo inoltre sottolineare che, nella concezione freudiana, se pure esistono tanti particolari eventi dell’infanzia, differenti da individuo a individuo, questi possono essere ricondotti, per il loro essenziale significato psicologico, ad alcune esperienze basilari (reali, immaginarie e simboliche) uguali per tutti gli individui, attraverso cui l’intera vita psichica viene ad essere strutturata. Nella concezione junghiana viceversa il “complesso” non necessariamente attinge all’esperienza infantile nei suoi momenti psicologicamente determinanti: qualsiasi difficoltà, turbamento, accadimento traumatizzante, di un passato remoto o recente, può essere responsabile dell’instaurarsi di un complesso. Ne consegue che nella concezione junghiana il complesso si caratterizza per almeno tre aspetti difficilmente compatibili con la teoria freudiana:
a) è possibile individuare un numero potenzialmente infinito di complessi;
b) il complesso è qualcosa di accidentale, separato, parassitario rispetto alla realtà psichica dell’individuo, che ne viene influenzata ma non strutturata;
c) il complesso finisce con l’essere identificato con un disturbo, una malattia, che deve essere debellata.
Proprio questi aspetti, in realtà in antitesi con i motivi più profondi della riflessione freudiana, hanno fatto la fortuna del termine “complesso” che andò incontro rapidamente ad una indiscriminata e fantasiosa proliferazione. Lo stesso Freud manifestò ben presto una notevole diffidenza nei confronti dell’abuso che si faceva di questo termine, preoccupato da una possibile banalizzazione delle sue scoperte, che avrebbe potuto ridurre la psicoanalisi ad una pittoresca “psicologia dei complessi”.
Nella psicoanalisi freudiana il termine “complesso” ha finito quindi, sulla scorta delle indicazioni dello stesso Freud, per essere praticamente abbandonato nella sua accezione più generale, e per essere conservato soltanto nelle espressioni “complesso edipico”, “complesso di castrazione”, “complesso paterno” (che del resto fanno riferimento alla stessa realtà psichica), per indicare appunto uno dei momenti cruciali dello strutturarsi della realtà psichica individuale.
Ma il complesso che probabilmente gode di più larga popolarità è il “complesso di inferiorità”, per la elementare genericità di significato che agevolmente gli può essere attribuita. Eppure è una nozione totalmente estranea alla psicoanalisi freudiana mentre costituisce uno dei cardini della psicologia fondata da Adolf Adler.